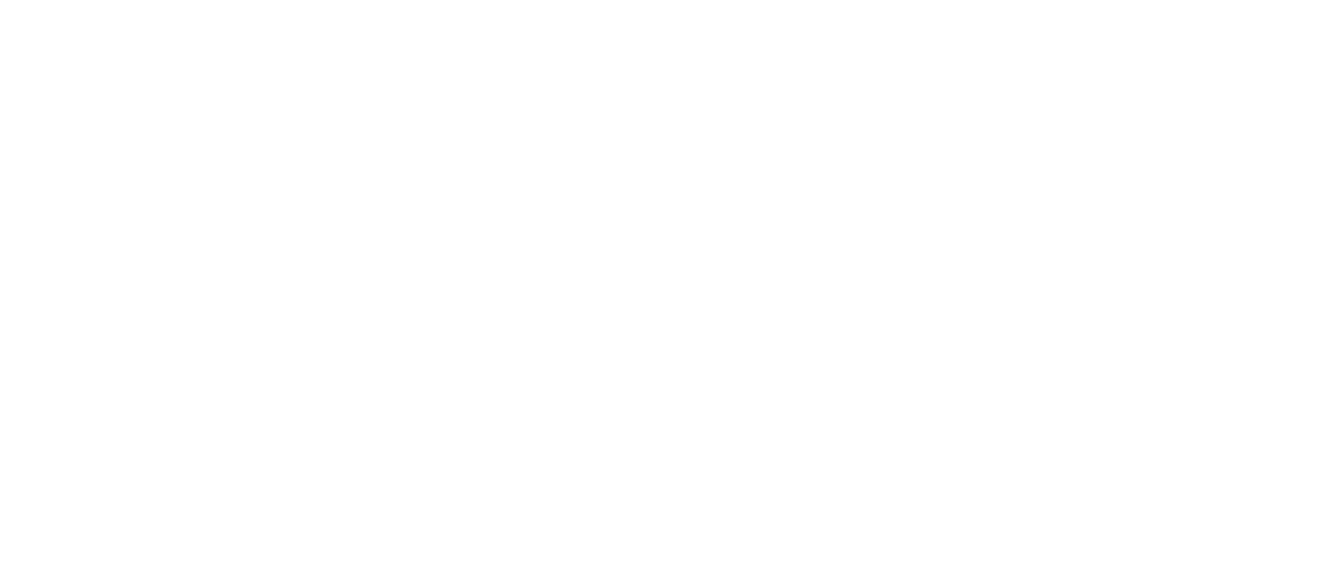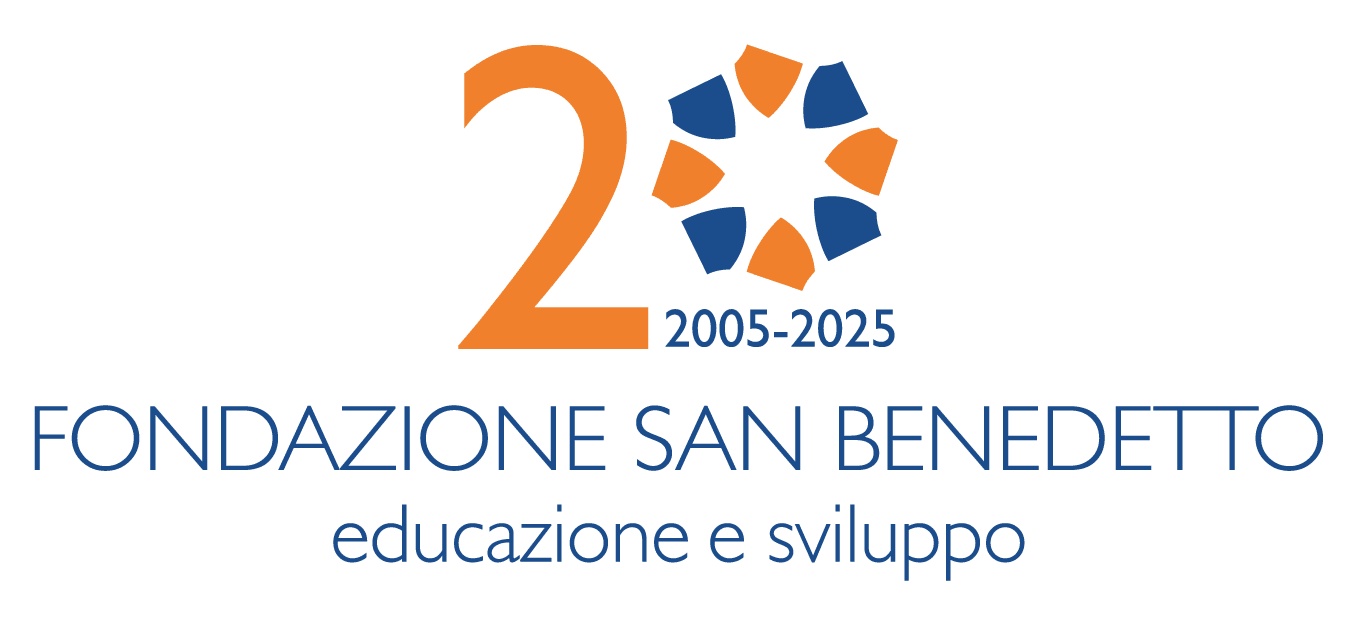Riascoltando Gaber
Riprendiamo il nostro appuntamento domenicale nel nuovo anno accompagnati da Giorgio Gaber. A Capodanno Rai 3 ha mandato in onda il docufilm «Io, noi e Gaber» che è possibile rivedere a questo link su RaiPlay. Un’occasione straordinaria per rivivere un pezzo di storia d’Italia attraverso la carriera e la vita dell’artista milanese scomparso ventuno anni fa. Eppure a distanza di tanto tempo nel percorso e nelle parole di Gaber possiamo ritrovare intuizioni e suggerimenti spiazzanti che riguardano la nostra vita di oggi. Come scrive Carlo Candiani nell’articolo pubblicato sul quotidiano online ilsussidiario.net, di cui invitiamo alla lettura, il docufilm «non è più il racconto di una carriera artistica, ma quello di un uomo dentro la propria storia e quella del popolo in cui è immerso, con mille contraddizioni, vissuta con l’intero corpo e anima».
Incontri sull’Unione Europea, iscrizioni solo in lista di attesa
Sono esauriti i posti per partecipare al ciclo di incontri sull’Unione Europea promosso dalla Fondazione San Benedetto, che inizierà venerdì 19 gennaio. Segno evidente di interesse per una proposta, che, come avevamo preannunciato presentando il programma, risponde a un’esigenza diffusa di conoscenza dell’Europa. Invitiamo comunque chi volesse partecipare e non si fosse ancora iscritto a registrarsi in ogni caso sul nostro sito a questo link. Formeremo una lista di attesa e in base alle richieste che riceveremo valuteremo la possibilità di allargare la partecipazione ad altri iscritti.
IO, NOI E GABER/ Il docufilm che racconta il cantante ma anche una generazione
di Carlo Candiani – da ilsussidiario.net del 4 gennaio 2024
1° Gennaio 2024, ore 21,20: mi accingo a godere della visione del docufilm “Io, noi e Gaber” che, meritoriamente, la RAI offre al vasto pubblico televisivo. Scorrono le immagini e il primo sentimento personalissimo è di “magone”. Infatti, l’inizio è dedicato alle origini della carriera di Giorgio Gaber nella Milano dei primi anni ’60, in pieno rimbalzo sociale dopo la ricostruzione post-guerra. Io sono nato in questa città, nella periferia bagnata dal Naviglio leonardesco che sfocia nella Darsena, porto a quel tempo attivo per i barconi che, trainati dai trattori, trasportavano sabbia e materiali edili, e proprio in quei giorni di maggio del 1957 nei quali al Palazzo del Ghiaccio, il rock’n roll entra in Italia e sul palcoscenico di quel Festival debuttano Adriano Celentano ed Enzo Jannacci, ai quali, negli anni immediatamente seguenti si aggiungono Giorgio Gaber e Luigi Tenco: ed è rivoluzione! I ragazzotti scardinano con il loro entusiasmo contagioso le regole della canzone nazionale ancora memore della tradizione melodrammatica e puntano sui ritmi frenetici che arrivano da oltreoceano americano (un misto di rock’n roll e jazz). I teenagers li celebrano subito come loro eroi musicali, ma i testi delle canzoni non sono così rivoluzionari come il ritmo esagitato ed elettrico: cantano la vita delle periferie.

Soprattutto Gaber (con l’aiuto delle liriche immortali di Umberto Simonetta, dimenticato nel docufilm, ma è l’unica pecca dell’impianto narrativo) con la sua musica fa risplendere la Milano del Giambellino, di Porta Romana, dei trani a gogò, delle osterie dove la piccola malavita si incrociava con il resto di umanità, fotografando un popolo appena uscito dalle temperie belliche della guerra civile e alla ricerca di una stabilità lavorativa e una dignità sociale.
È un primo “step” da gigante della comunicazione artistica: è il Gaber televisivo, quello della neonata RAI, la televisione impegnata nella missione di unire l’Italia ancora non completamente scolarizzata ma aggrappata alle tradizioni delle generazioni precedenti, quella agricola in via di estinzione e quella religiosa/clericale a rischio sclerosi. Sono gli anni “spensierati” in coppia con Jannacci, delle sfide rock con Celentano, dei duetti con Mina.
Ma gli anni ’60 scorrono veloci e arriva prepotente, dalla Francia, l’onda contestatrice del ’68: il conformismo della società borghese viene messo alla berlina. È una specie di un confuso liberi tutti che interroga gli operai, gli studenti e gli intellettuali, mentre le regole religiose vengono travolte. Gaber è attratto da questo vento di cambiamento e la sua nuova produzione musicale si apre alla critica sociale più pungente. La censura televisiva, però, si fa più invasiva e l’artista milanese medita un gesto netto e irrevocabile: se lo spazio televisivo, quello famigliare, si fa sempre più esiguo, tutto lo sforzo creativo sarà gratificato e veicolato dalle messe in scena del “Teatro Canzone”.
La narrazione del docufilm è puntuale nel raccontare questo passaggio storico di Gaber, attraverso le cronache politiche e sociali: dall’incontro con il pittore anarchico toscano Sandro Luporini, impegnato nell’ideazione dei testi, scaturirà l’epopea artistica del teatro “civile”, testimone per tre decenni degli avvenimenti della cronaca e della storia politica italiana, sempre pronti a segnalare con ironia sempre più “urgente” e sempre meno “leggera”, le contraddizioni umane ed esistenziali del “nuovo che avanza”. E qui, l’affondo del film è insuperabile.
Attraverso l’encomiabile varietà di interventi fra i testimoni dell’arte gaberiana, provenienti dalle diverse formazioni culturali d’origine, l’atmosfera narrativa si fa più “tesa”; perde necessariamente una certa leggerezza, si adegua ai temi sempre più profondi toccati dal duo Gaber/Luporini, sezionandone e sviscerandone il nocciolo del pensiero. In primo piano, ecco canzoni come “Il dilemma”, “La mia generazione ha perso”, “Scusate se parlo di Maria”, “Quando eravamo comunisti”; e la galleria di voci e volti si snocciola interminabile e curiosa.
Tutti i coinvolti sono portatori di un contraccolpo, di una riflessione estrema e scarnificante, di una domanda ancora attuale, anche permettendosi qualche timido dissenso. Dalle lampanti perplessità dure a morire e dall’imbarazzo dei politici Mario Capanna e Pier Luigi Bersani, al disagio per le provocazioni “gaberiane”, ancora vivo e sanguinante degli autori e attori ‘d’area’ come Gino & Michele, Michele Serra e Claudio Bisio, fino alle citazioni esistenziali del giornalista Massimo Bernardini, nella sua gioventù tra i responsabili del fitto rapporto personale tra Gaber e una certa parte del mondo cattolico, travalicando superati schemi ideologici, e poi le memorie dello stesso Luporini, quelle di Mogol e dei collaboratori della “Fondazione Gaber”, gli aneddoti dei colleghi Gianni Morandi, Ivano Fossati, Ricky Gianco, della figlia Dalia manager in comunicazione musicale e di Massimiliano Pani (figlio di Mina, anche lui produttore discografico della illustre madre), di Lorenzo “Jovanotti” Cherubini (che uno si domanderebbe cosa c’entri con Gaber?), eppure titolare di uno dei più interessanti spunti riflessivi: “Non esistono le generazioni, esistono le persone concrete con nome e cognome”.
Insomma, ormai il docufilm ha voltato pagina: non è più il racconto di una carriera artistica, ma quello di un uomo dentro la propria storia e quella del popolo in cui è immerso, con mille contraddizioni, vissuta con l’intero corpo e anima. Un uomo considerato ormai tra i più grandi artisti italiani dal dopo guerra. Tutto si fa più impegnativo per lo spettatore, il ritmo narrativo scorre fluido ma intenso: il bravo Riccardo Milani nel suo ruolo di regista non censura nessun intervento, non antepone un suo pregiudizio, non strumentalizza ma lascia spazio alle libere voci che testimoniano il libero pensiero di Gaber. È come una seduta di analisi o stare in un confessionale, confrontandosi con le parole del Teatro Canzone. E così i pensieri vengono sostituiti dalle immagini, quelle di vent’anni fa, le ali di folla, i funerali nell’Abbazia di Chiaravalle nell’estrema periferia milanese, in quel freddo gennaio 2003. Fino allo stratagemma narrativo di quell’esodo finale che vede arrivare da ogni parte i testimoni coinvolti per incontrarsi riuniti davanti al palcoscenico e applaudire in un’ultima ovazione l’eroe indimenticato nel suo ultimo e definito monologo.
Che meraviglia ai nostri occhi! Che profondità di pensiero per le nostre orecchie travolte dalle banalità quotidiane! Che respiro di vita per il nostro cuore! E quanto ancora si vorrebbe stare lì, davanti a quel palcoscenico nell’attesa di un nuovo monologo, una nuova canzone, una nuova “urgente” provocazione che ci faccia saltare sulla poltroncina!
Non perdetelo questo gioiello di film (disponibile sul canale RaiPlay), ringraziate per la passione e l’affetto con cui è stato ideato e realizzato, e lasciamo che queste ultime parole di Gaber, quasi un testamento, si insinuino in qualche parte della nostra memoria più profonda:
“E tu mi vieni a dire
quasi gridando
che non c’è più salvezza
sta sprofondando il mondo.
Ma io ti voglio dire
che non è finita
che tutto quel che accade
fa parte della vita”.
Tag:Giorgio Gaber