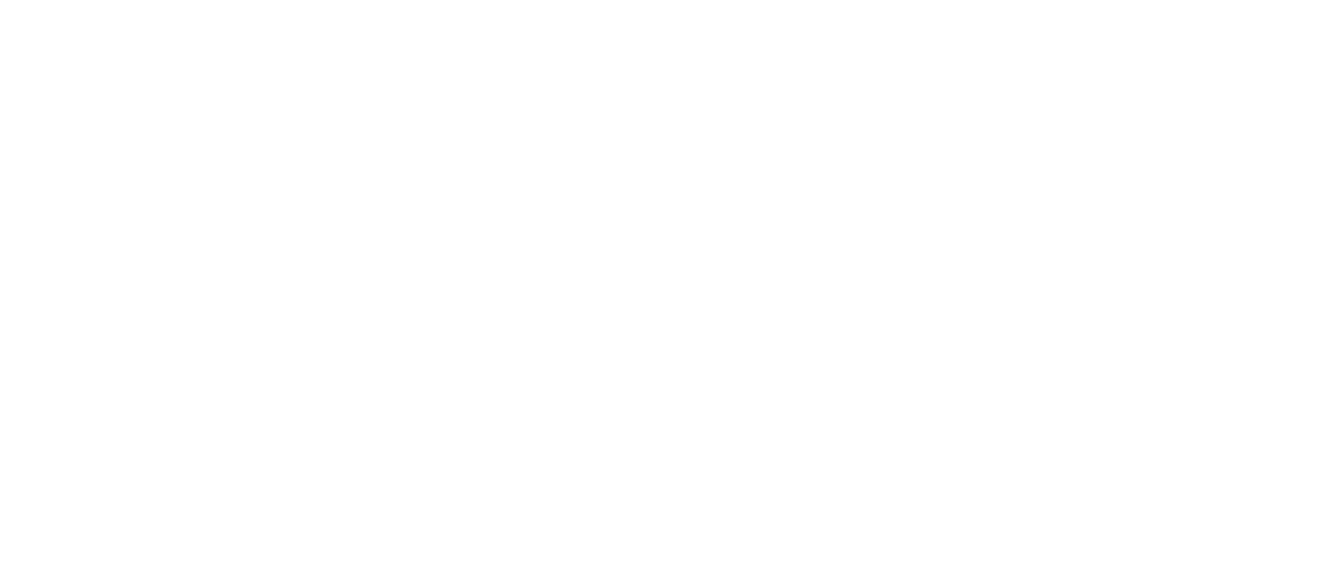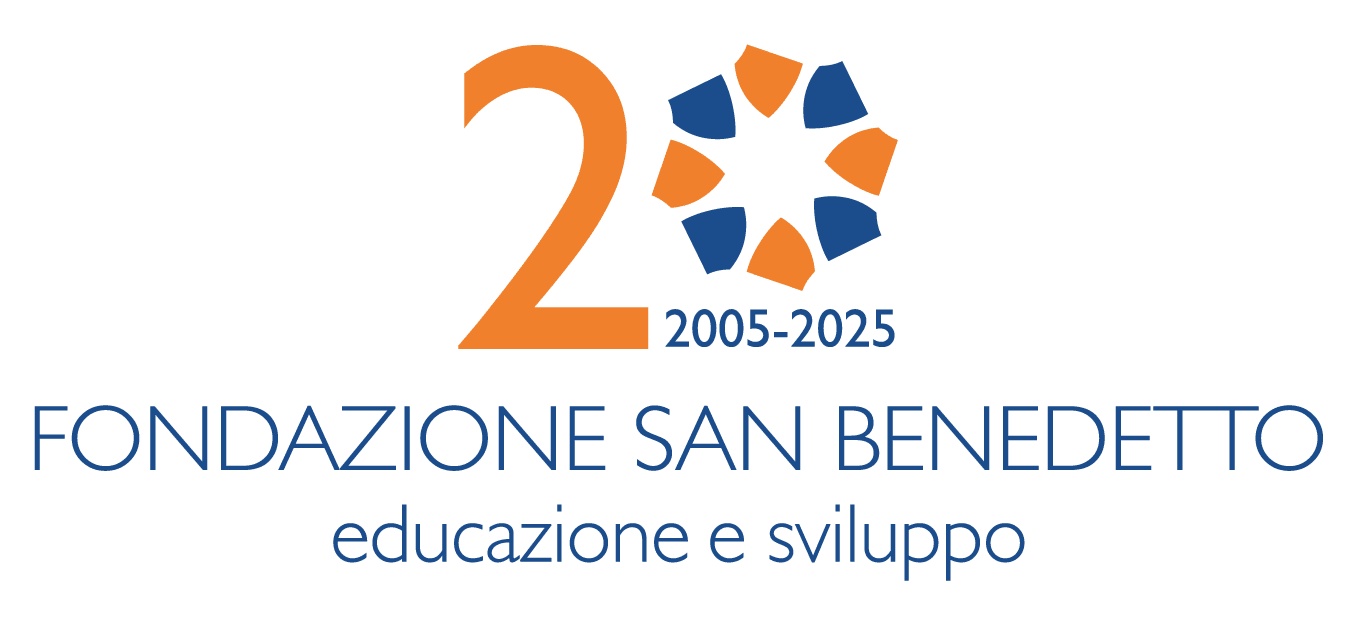Intelligenza artificiale, dipendenza dagli smartphone e dai social network, multitasking mediatico, uso sempre più pervasivo delle tecnologie digitali, difficoltà a distinguere le notizie vere dalle fake news. Sono solo alcuni aspetti contrastanti del mondo in cui siamo quotidianamente immersi. Su questi temi, tra luci e ombre, vogliamo soffermarci nella nostra newsletter per stimolare la riflessione. Lo facciamo attraverso due articoli, che consigliamo di leggere, dell’epistemologo Gilberto Corbellini sul Sole 24Ore, e del direttore dell’Istituto Mario Negri Giuseppe Remuzzi su La Lettura. Entrambi gli interventi, che partono da approcci e punti di vista diversi, documentano alcune ricadute che l’impatto con le tecnologie digitali sta avendo sulle nostre vite e sul cervello umano, di cui occorre essere consapevoli. Un impatto che rischia di essere particolarmente aggressivo sui più giovani.
foto uberoffices.com
Non si tratta assolutamente di demonizzare la tecnologia con inutili battaglie di retroguardia, fuori tempo massimo, o con altre idiozie del genere. Ci interessa invece utilizzarla in modo critico e consapevole; e questo è possibile. Tutto, come sempre, dipende dal soggetto, da ciascuno di noi. Come ha scritto recentemente lo scrittore Alessandro D’Avenia, se l’homo curvatus (quello che passa le sue giornate con lo sguardo curvato sullo smartphone e non si accorge più della realtà) «ha meno occhi non è colpa del telefono, ma di un cuore che quel telefono ha trovato vuoto». Così qualche giorno fa sul Corriere un lettore descriveva in una piccola lettera una scena emblematica: «Per un piccolo intervento, sono da pochi giorni in una camera d’ospedale a tre posti. Fino a ieri c’era anche Paolo, un degente boomer come me, andato via stamani. Da oggi ecco arrivare due sui 40 anni. Completamente rapiti dal cellulare, stanno distesi sul letto a guardarlo come un dio. Zero saluti, zero sguardi, zero di tutto. Con Paolo, invece, è bastato uno sguardo per conversare, sapere dove vive, che ha una figlia, che lui è in pensione, che non ha paura dei medici, prende farmaci e sta bene. In due giorni ci si è confidati giusto un po’, per rendere meno vuoto il tempo e non sentirsi soli. I due digitali 40enni invece… che tristezza l’adorazione di quel loro dio tascabile».